Pubblicato originariamente su Pagina99 sotto il titolo “Vi racconto gioie (poche) e dolori dell’imprecariato”. Illustrazione di Krisis Publishing.

A prima vista, ciò che accomuna quell’ampio segmento demografico che va sotto il nome di Millennials è soprattutto la tecnologia. I nati orientativamente tra il 1980 e il 2000 sono infatti i primi ad aver vissuto pienamente la rivoluzione digitale, e già ne commemorano nostalgicamente gli albori. Eppure c’è un altro aspetto che contraddistingue questa generazione rispetto a quelle precedenti. Mentre i baby boomer hanno potuto contare su una carriera stabile e la Generazione X ne ha lamentato i limiti, per i Millennials un percorso privo di deviazioni risulta illusorio se non addirittura antiquato. È l’idea stessa di carriera che vacilla, a fronte di un orizzonte condiviso caratterizzato dall’incertezza costante.
Coloro che hanno oggi venti o trent’anni sono intimamente coscienti che il baricentro della propria identità professionale è situato nella propria persona piuttosto che nelle imprese con cui temporaneamente collaborano. Sono essi stessi l’impresa o, per dirla con Michel Foucault, agiscono come «imprenditori di se stessi». Se si pensa all’abbondante uso di formule simili per presentarsi su Facebook, l’espressione usata dal filosofo francese nel ‘79 appare oggi banale, e dunque profetica.
Ma cosa significa essere imprenditori senza avere una vera e propria azienda da gestire? In gioventù Joseph Schumpeter, influente economista viennese, considerava gli imprenditori una specie rara che si colloca in cima alla piramide sociale poiché dotata della preziosa capacità di innovare. A partire da simili premesse, Peter Drucker, guru del management, ha sostenuto che, per accelerare l’innovazione, la società tutta sarebbe dovuta diventare imprenditoriale, sbarazzandosi di quel disincentivo a progredire che è il posto fisso. La visione di Drucker è oggi realtà: a fronte di una precarietà economica e lavorativa diffusa, la piramide di Schumpeter si è ribaltata. Tutti sono chiamati alla libera impresa (persino gli impiegati, come suggerisce il concetto di intrapreneur). È questo il senso generale di ciò che possiamo chiamare, con una dose di ironia e altrettanta amarezza, imprecariato.
Quando lo spirito imprenditoriale cala sul popolo, l’imprenditoria diventa imprenditorialità. Una prassi specifica si sublima a senso comune e talvolta a leggendario stato di natura. L’imprenditore sociale bengalese Muhammad Yunus, pioniere del microcredito, è ampiamente citato per aver sostenuto che «tutti gli esseri umani sono imprenditori. Quando vivevamo nelle caverne, eravamo tutti lavoratori autonomi.» Mentre abbondano i programmi televisivi che esaltano l’attitudine imprenditoriale (tra cui The Apprentice, Dragons’ Den o il più recente Planet of the Apps), si diffonde il culto della Silicon Valley e dei suoi CEO, le cui gesta vengono narrate in Italia dall’ultraseguito vlogger Marco Montemagno. La retorica imprenditoriale ci pone però di fronte a un paradosso: pur inquadrando i vari Zuckerberg, Musk e Mayer come soggetti sui generis, ci si affanna per emularne il carattere e le abitudini, prendendo nota della loro dieta settimanale e delle ore di sonno che si concedono. La devozione imprenditoriale sfocia in uno sconsiderato esercizio di auto-aiuto.
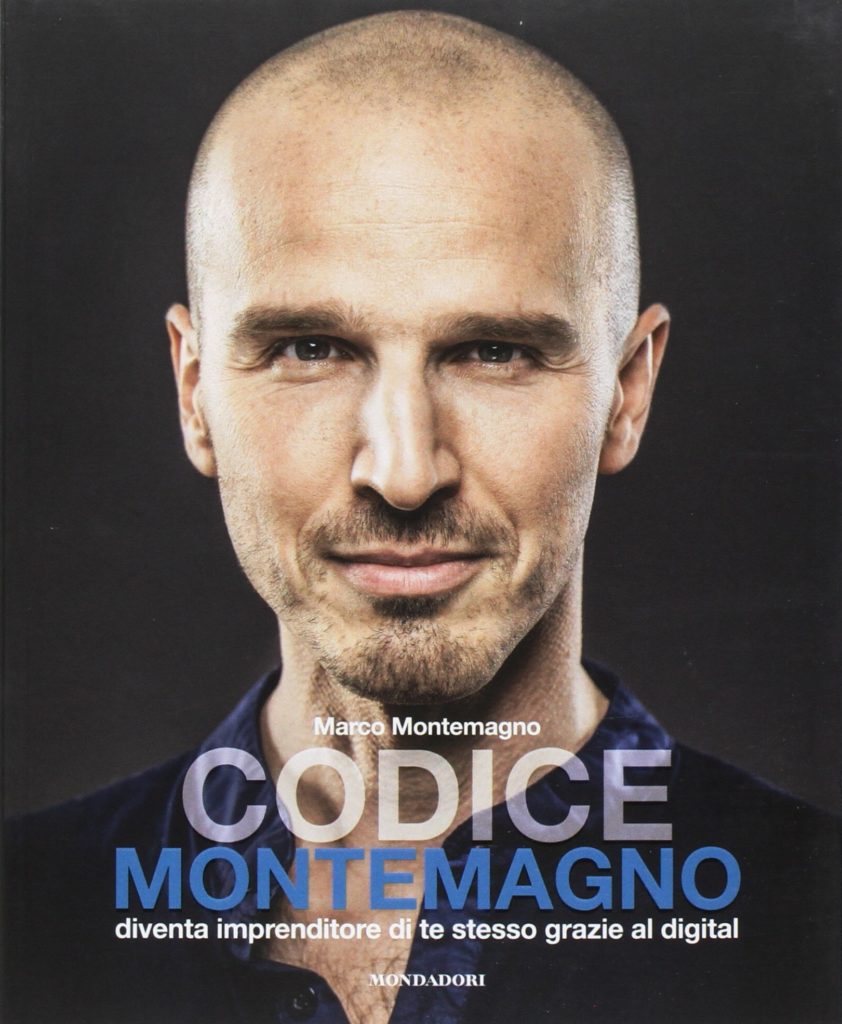
Copertina del libro di Marco Montemagno, pubblicato nel 2017.
Le ricadute di questa pressione atmosferica si misurano psicologicamente, emotivamente e affettivamente. Fake it till you make it, «fa finta finché non ce la fai», è un’espressione che incarna bene le turbe esistenziali dell’imprecariato. In ambito strettamente imprenditoriale, si ricorre al motto nel momento in cui si simula l’esistenza di un prodotto per ottenere i finanziamenti necessari alla sua realizzazione. Invece, a livello di psicologia pop, lo slogan suggerisce di fingersi felici per far sì che alla fine ci si senta davvero così. Mescolando le due accezioni, l’individuo diventa un prodotto incompleto in costante ottimizzazione che ricorre a un ottimismo manifesto per mostrarsi autonomo agli altri e a se stesso. Col rischio che, essendo dichiaratamente padrone del proprio destino, la responsabilità dei propri fallimenti ricada soltanto su di lui.
E così incontriamo il fashion designer che paga l’affitto facendo consegne a domicilio o il disoccupato che si definisce startupper in calce alla mail. La figura in cui ci imbattiamo più raramente è però quella che adotta apertamente il punto di vista del precariato, dato che tale etichetta contraddice l’obbligatoria posa imprenditoriale. Ciò che contraddistingue l’attuale impasse professionale (e dunque esistenziale) è una dissonanza cognitiva generalizzata. Una condizione simile a ciò che Raffaele Alberto Ventura chiama «disforia di classe» nel suo Teoria della classe disagiata. Se per Ventura il ceto medio si sente ricco pur essendo destinato alla povertà, agli imprecari tocca mostrarsi ricchi di potenziale alla luce di una crescente povertà di opportunità per esprimere le proprie capacità.
Oltre alla dimensione esistenziale dell’imprecariato, si può rilevare più concretamente la reciproca influenza tra imprenditorialità e precarizzazione nei rapporti economici, contrattuali e sociali. Nel Regno Unito i corrieri del sindacato indipendente IWGB, al soldo della gig economy, rivendicano i propri diritti al grido di «non siamo imprenditori». Negli Stati Uniti si diffonde ciò che Paolo Mossetti chiama imprenditoria della disperazione: un crescente numero di famiglie è costretta a scommettere sul crowdfunding per finanziare le proprie spese mediche, inventandosi campagne che richiedono doti manageriali e familiarità con la Rete. In Giappone si chiamano freeter (neologismo che unisce l’inglese ‘free’ al tedesco ‘arbeiter’) quei lavoratori senza posto fisso che si dividono tra vari lavoretti di basso profilo e il cui rapporto con la libertà suona come una beffa. Tornando in Italia, si assiste agli affanni del popolo delle partita Iva, i cui membri sono spesso indipendenti solo sulla carta, e intanto nascono programmi statali per convertire i NEET, giovani che non hanno un lavoro e hanno smesso di cercarlo, in veementi startupper. Esistono infine posizioni dichiaratamente militanti sul terreno dell’imprecariato. Nel suo suo recente Non è lavoro, è sfruttamento, Marta Fana offre un desolante ritratto in cui la stessa precarietà emerge come il risultato di un trentennio di politiche a favore dell’impresa e a scapito dei lavoratori.

San Precario esibito durante una dimostrazione. Foto di Samuele Ghilardi.
Se fin qui abbiamo interpretato l’imprenditorialità attraverso la lente della retorica, è forse possibile ravvisare una genuina energia imprenditoriale intrinseca al precariato. È ciò che propongono Michael Hardt e Antonio Negri in Assembly, saggio programmatico che estende la nota trilogia dell’Impero. Un’«imprenditoria della moltitudine» rigetta la figura dell’imprenditore demiurgo che estrae innovazione orchestrando dall’alto la cooperazione e, al contrario, favorisce l’amministrazione autonoma e orizzontale del corpo sociale, evidente agli occhi degli autori nelle dinamiche dei nuovi movimenti insurrezionali. D’altronde, il brand San Precario, creazione collettiva e anonima emersa durante i primi tumulti nati esplicitamente all’insegna del precariato, tradisce quantomeno un’inclinazione imprenditoriale “dal basso”.
Tuttavia, a distanza di più di un decennio dalla prima apparizione del santo, non c’è ancora accordo su quale sia la fondamentale mission del precariato. Alex Foti, attivista che ha contribuito alla canonizzazione di San Precario, indica tre obiettivi principali: potere urbano, giustizia climatica e reddito universale di base (UBI). Ironicamente quest’ultimo traguardo fa gola proprio ad alcuni di quegli imprenditori statunitensi che sono attualmente oggetto di culto. Da qui il rischio che una modica somma di denaro offerta incondizionatamente, se mai dovesse essere realmente distribuita a tutti i cittadini, possa seppellire una volta per tutte quel che resta dello stato sociale. E dunque, mentre attendiamo con angoscia o trepidazione l’avvento dell’UBI, le strade percorribili sembrano due: replicare il mantra dell’imprenditorialità precarizzata oppure tentare di organizzare collettivamente un precariato imprenditoriale.
Also published on Medium.
